Mer, 10 Dic 2008
Leggendo il numero 30 (ottobre 2008) della rivista Dharma, ho trovato un articolo particolarmente interessante, del birmano Sayagyi U Ba Khin. Stimolante per più di una ragione. Prima di tutto non è “farina” della famiglia detta del buddismo mahayana a cui -più o meno consapevolmente- aderiscono i frequentatori dei dojo zen italiani.
Vi si usa un linguaggio molto diverso da quello cui siamo abituati. Sia nel lessico (molti i termini in pāli) sia nel tipo di logica: anche le finalità stesse del buddismo sono presentate da un’angolatura inusuale. Tutto questo, se vogliamo capire il senso profondo, ci costringe a leggere con attenzione, a consultare dizionari per capire il significato delle parole e poi indagare l’origine, il fondamento sul quale poggiano molte delle affermazioni che vi troviamo.
Operazione che non siamo (quasi) più abituati a fare, dando spesso per scontato che i discorsi “sullo zen” siano solo di due tipi: quelli che dicono ciò che già sappiamo -o, meglio: pensiamo- anche noi, e gli altri: quelli sbagliati, scritti da chi “non ha ancora capito”.
Gli argomenti trattati da Sayagyi sono quelli basilari: perché ha senso la pratica buddista e come funzionano gli insegnamenti dentro di noi. Vi propongo alcune affermazioni che -a mio parere- valgono da sole la lettura dell’articolo: “Sīla o vita etica è la base per il samādhi” (p. 9) e poi: “Il samādhi si costruisce sul sīla” (p. 16). “Solo se il samādhi è buono si può sviluppare paññā” e “Per paññā si intende la comprensione di anicca, dukkha e anattā” (p. 9). L’acquisizione che “Il samādhi si costruisce sul sīla” da cui poi discende tutto, è una conquista faticosa che annuncia altre fatiche spirituali e questa fatica, il suo rifiuto, è uno dei motivi -a mio parere, naturalmente- per cui vi sono praticanti zen che girano vanamente in tondo. La differenza tra zz e un exploit di tipo ginnico o un esercizio di igiene mentale, è proprio quella.
4 Commenti a “Theravada: chi era costui”
Se volete, lasciate un commento.
Devi essere autenticato per inviare un commento.

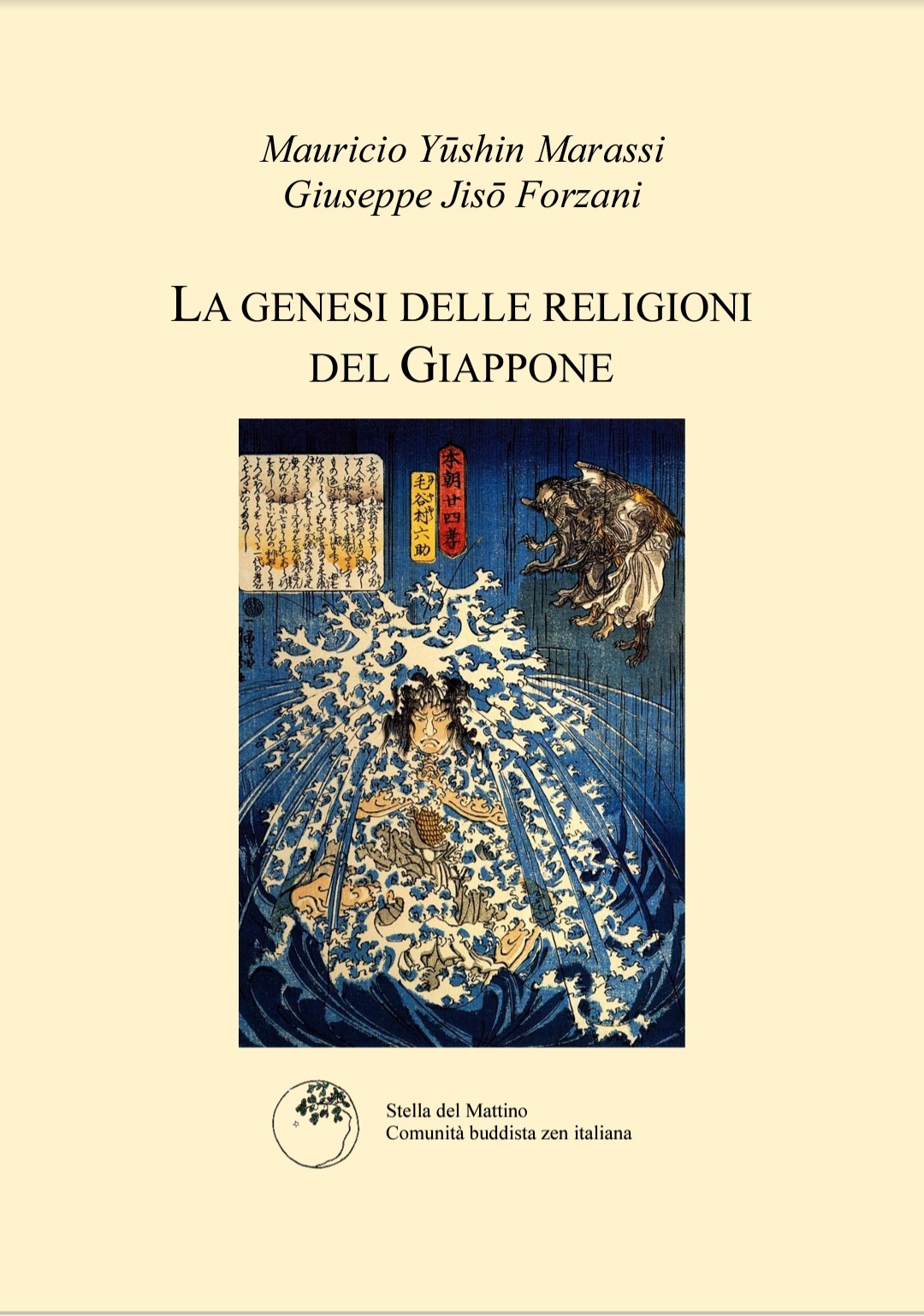






14 Dicembre 2008 alle 11:59 am
Buongiorno a tutti, dopo un po’ di pausa mi sorge questa riflessione. La tendenza ad accettare come vero o semplicemente come valido quello che già si conosce e che fa parte di noi è una cosa molto umana da cui nessuno è immune.( Talvolta è anche una necessità cognitiva: trovare cose che confermono le nostre idee per poi solo sucessivamente modificarle.)
Ma se si vuole veramente entrare in dialogo con una persona o una realtà diversa ( e non credo di dire niente di nuovo soprattutto per chi è all’interno della Stella del mattino)si dovrebbe essere veramente disposti a considerare le proprie ideee e il proprio credo come una delle possibili visioni della realtà. A scanso di equivoci non voglio con questo dire che una cosa vale quanto un’ altra o che sono intercambiabili ( ma questo credo sia già assodato da tempo ), semplicemente mi sembra che ci voglia uno sforzo costante e consapevole per tenere aperta, o aprire, la porta del dialogo, a qualsiasi livello: personale, lavorativo, religioso.. ( soprattutto, direi, in quei campi in cui ci si sente “esperti” e ci si trova di fronte a chi, si presume, ne sa meno di noi…) A volte, mi sento di poter dire, si confina il “dialogo” all’ interno di alcuni aspetti della nostra vita, quasi fosse una cosa da farsi in certe particolari occasioni ( magari con chi è già aperto al dialogo .)
Mi vien da rammentare che lo scoglio più grande non è quello di far la pratica ( che naturalmente pur veicola in sè apertura e condivisione..), ma il non lasciare chiuso nella pratica quello che dovrebbe essere l’ atteggiamento nella vita quotidiana.
Rimanendo fermo il fatto che è una gran fatica. Ciao
14 Dicembre 2008 alle 12:25 pm
Grazie Marta per il tuo commento. Hai un’opinione lusinghiera di chi è “all’interno della Stella del mattino”, grazie. Penso varrebbe la pena riflettere un poco su che cosa significhi “non lasciare chiuso nella pratica quello che dovrebbe essere l’atteggiamento nella vita quotidiana” e che relazione ciò abbia con quello che chiami dialogo.
14 Dicembre 2008 alle 7:40 pm
Dato che questo “argomento ” mi sta particolarmente coinvolgendo in questi ultimi periodi, colgo l’ occasione per esprimere ad alta voce ( si fa per dire ) alcune riflessioni. Mi scuso se parlo della mia personale esperienza e se non uso termini “tecnici” ma mi sentirei a disagio ad usarli date le mille angolature e interpretazioni che possono avere.
Nell’ atteggiamento della pratica ( meditazione. lettura del vangelo e studio di testi….) si è portati , direi quasi istintivamente, a lasciarsi compenetrare, a lasciarsi quasi plasmare da quanto avviene in noi in quei momenti. Forse anche perché accettiamo a priori ( anche se dopo un lungo percorso ) che quello che stiamo “facendo” è una parte essenziale della nostra vita. ( A volte ci si lascia trasportare troppo e si pensa che solo quella sia la vita vera).
Poi nella normale vita quotidiana non si è più disponibili ad accettare ” a priori “quello che viene ( sia esso persona, fatto ….) ma si pone immediatamente un filtro valutativo che fa emergere le categorie di giusto, sbagliato, piacevole non piacevole… ( non serve che dica che spesso le cose sono sbagliate ..)che incasellano la realtà. Al massimo si arriva a tollerare, a compatire ( nel senso coumne del termine). Quella parte di verità che mi viene incontro non la riconosco come mia. Ecco quindi il non- dialogo, la non- pace, l’ arrabbiarsi quando le cose non vanno come “dovrebbero” ( dal mio punto di vista naturalmente!).
E magari mi lamento perchè non c’è dialogo! Si vive una frattura tra ciò che si vive durante la pratica e ciò che si vive nella quotidianità, nonostante tutti gli sforzi mentali per far quadrare il cerchio.
Ma se il dialogo è, prima di tutto, ascolto di ciò che è diverso da me e partecipazione reale e non fittizia, allora, è proprio nella vita di ogni giorno, penso, che “la pratica religiosa ” porterà “frutto” ( lo so che qui potrei essere fraintesa ) o meglio diventerà pratica di vita: cercando continuamnete di togliere la polvere che si accumula per le troppe parole, per il rumore….e ricominciando sempre da zero. Ma non perché questo mi debba rendere migliore ( come neanche il fatto in sè della pratica rende migliori ) ma perchè forse è una delle poche cose che risponde alla mia ricerca di senso. E’ un atteggiamneto che mi permette di azzerare continuamente gli errori compiuti da me e dagli altri e di poter intravedere sempre nuove strade. Mi permette di cancellare la ricerca della “meta” e di essere presente in ciò che mi accade cercando il mio posto, o meglio cercando di sentirmi al mio posto.
Chissà se mi sono spiegata: quello che volevo forse semplicemente dire è che, solo se nelle mie “mani vuote” della pratica posso vedere anche “le mani vuote” nella normale vita, recupero il senso della vita globalmente intesa. Grazie dell’ attenzione
15 Dicembre 2008 alle 12:02 pm
Il senso di “dialogo” inteso come rapporto continuo, giornaliero -apparentemente banale- con ciò che ci circonda mi piace assai. E il resto anche. Apprezzo molto. Grazie.