Ven, 26 Feb 2016
Un’occasione d’incontro tra buddisti e cristiani: sabato 5 marzo nell’eremo camaldolese di Montegiove vi sarà una giornata dedicata ad osservare come cristianesimo e buddismo si siano occupati del problema della sofferenza.
Secondo la storia del buddismo antico, certamente apocrifa nei fatti ma altrettanto autentica nel senso, il buddismo nasce e si sviluppa proprio in relazione alla sofferenza che affligge ogni essere di questo mondo. La dissoluzione della sofferenza è l’unico scopo dichiarato di questa forma di spiritualità. Non ostante ciò, non vi sono molti testi che si siano dedicati ad esaminare questo problema in modo esplicito.
Soprattutto nell’ambito del buddismo zen, spesso il fine di tutto pare essere, o viene presentato come se fosse, la cosiddetta “illuminazione”: stato particolare e definitivo che, una volta riconosciuto e asseverato con apposito certificato da un altro “illuminato” con certificato, non si perde più, qualsiasi sciocchezza indirizzi la nostra vita.
Ma anche fosse, a che pro? Una volta gonfiato il collo e fatta la ruota per far vedere al dotto pubblico come siamo illuminati, alla fin fine tignola e ruggine consumano mentre malattia vecchiaia e morte regnano indisturbate sul nostro destino.
L’illuminazione non serve a nulla. Grazie al cielo il buddismo si occupa d’altro.
Allora: la sofferenza come ritorno alle origini.
Trovate qui sotto il testo da scaricare, dal titolo: La sofferenza come punto di partenza
Il punto d’arrivo… un’altra volta.
29 Commenti a “La sofferenza, il buddismo e il cristianesimo”
Se volete, lasciate un commento.
Devi essere autenticato per inviare un commento.


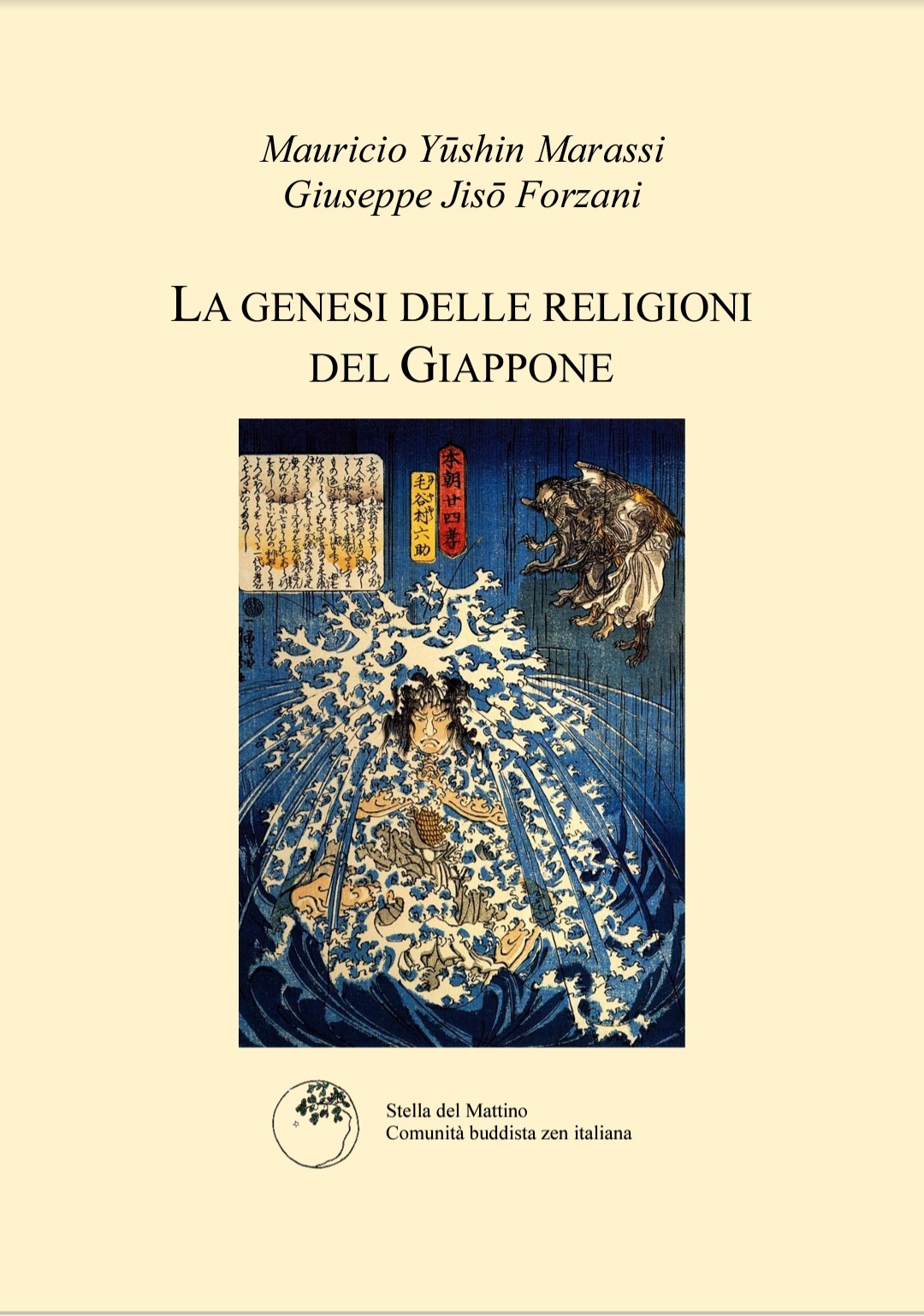






5 Marzo 2016 alle 1:03 pm
Come promesso ho aggiunto in fondo al post il testo dell’intervento di oggi a Montegiove.
Un commento “a caldo”: quando i cristiani potranno parlare di cristianesimo utilizzando testi buddisti il “gioco” diventerà davvero interessante.
22 Marzo 2016 alle 12:59 pm
Un OT: qui ho trovato un punto di vista interessante su madre Teresa di Calcutta e la sua imminente santificazione.
Invito a leggerlo.
28 Marzo 2016 alle 12:58 pm
Una pagina per me chiara ed esaustiva rispetto all’orientamento della prassi, che ripropone una (la) domanda radicale: Perché la “religione”?
La fede come “trascendenza”, ovvero oltre se stessi, oltre l’immediatezza della sua utilità?
Una riproposizione del senso radicale di fronte alla fine: una riproposizione del fine
Ps: qui una interessante pro-vocazione
28 Marzo 2016 alle 4:08 pm
Ciao Dario.
Mi piacerebbe sapere come c’è finito e perché, quel tale (e la tavola) sul lungo tetto.
Molto ben scritta la pro-vocazione, grazie.
Mi interessa di più la domanda del tuo commento. Da un po’ di tempo in qua sostengo la tesi/pro-vocazione che se la religione non è per un’esigenza e non la soddisfa non val la pena dedicarvi particolare tempo, energie, attenzione. Questo suscita a volte il tentativo di giustificare la religione da parte di chi sente di appartenervi. E i cattolici (suppongo tutti i cristiani, però) in quella parte sono in difficoltà. Non per “colpa” di Gesù, che ha eliminato dalla scrittura antica il 99,9% della enorme quantità di violenza che contiene. Già questa sarebbe un’ottima esigenza soddisfatta. Ma per vera e propria colpa loro: discutono di trinità o maternità di Dio/dio, di resurrezione, di martiri e santi, di valori irrinunciabili ecc. ma non si chiedono che cosa ci stanno a fare lì. Qual è il valore, il merito di tutto ciò.
Da sbadigliare sino a slogarsi le mascelle.
28 Marzo 2016 alle 7:20 pm
“Esigenza”: una parola apparentemente (penso)semplice ma che in questo caso contiene la totalità del panorama delle “questioni di senso” dell’umanità.
La domanda radicale: è “che cos’è” questa “esigenza”? da dove nasce? perché nasce?
Dalle religioni storiche come dalla religiosità senza Dio (penso a R. Dworkin) le risposte sono differenti.
“Precipitata da Iperuranio sulla terra”, la risposta del pensiero adesso la ritroviamo “semplicemente” nei meccanismi del cervello(v articolo sopra)?
28 Marzo 2016 alle 7:50 pm
Capisco. Ma nel caso sono molto più terra terra (rispetto all’Iperuranio…).
Parto da un dato più o meno incontrovertibile: grazie alla biografia agiografica (Asvagosha, per lo più) del Buddha ed al Dhammacakkapavattanasutta, intelligentemente posto dalla tradizione come “il primo discorso del Buddha”, si può dire che il buddismo nasca come risposta al problema della sofferenza, dolore, disagio di vivere. Ovvero: se quella è la tua esigenza/problematica nell’essere uomo/donna, allora il buddismo è un’opzione possibile. Quindi ha un senso molto chiaro il perché “diventare” buddisti.
Così posso chiedere a un muslim o a un cristiano (ad un ebreo no: si è tali -di fatto- solo per nascita. La via per diventare ebrei è proibitiva): perché dovrei diventare muslim, cristiano? Che cosa hanno da offrire queste religioni all’uomo? Sino ad ora le risposte sono riassumibili (un po’ grezzamente) con: “la Verità”. Che non è poco, intendiamoci. Ma per vivere mi serve a poco.
Il fatto è che nei miti fondativi del cristianesimo e dell’islàm una risposta più articolata ci sarebbe: basta leggere che cosa promette Dio ad Abramo e poi a Mosé in cambio di obbedienza ed adorazione esclusiva. Solo che, pare, nessun cristiano/muslim è disposto a rispondere che se divengo muslim o cristiano ottengo da Dio territorio, pascoli e numerosa progenie.
E qui veniamo al senso della mia tesi/pro-vocazione: c’è un grosso, grossissimo problema culturale da affrontare in tutte e tre le religioni abramitiche, che riguarda la scrittura. Sino a che non lo si affronterà a fondo ci saranno guerre per motivi misti alla religione, come ci sono ora.
1 Aprile 2016 alle 8:30 am
Riguardo agli ultimi commenti qui sopra, Giorgio (grazie) mi ha mandato un articolo, di Robert Mickens, molto interessante. Una sorta di apologia del cristianesimo cattolico che però, a suo e mio parere, finisce per funzionare al contrario.
Al punto da ingenerare (in me, che sono malpensante) il dubbio che sia stato scritto per motivi opposti a quelli apparenti.
Vi si trovano infatti frasi come “Questa è la conclusione a cui tante persone sembrano essere arrivate nelle nostre società più sviluppate. Quando finalmente sganciano la loro supposta fede (o almeno la loro adesione ad una comunità di chiesa) dalla sua connessione con la paura, che cosa trovano? Una Chiesa che è ampiamente irrilevante per la loro vita, a parte il fatto di costituire un gruppo sociale o una rete di amici – per coloro che sono fortunati”
Trovate qui l’articolo completo.
2 Aprile 2016 alle 5:34 pm
personalmente ho lasciato perdere. cattolicesimo o meno, la fede ci viene insegnata come aderenza a quella norma cui siamo capitati vicino al momento di nascere. Le chiese sono sempre state il modo per rendere mansueta la gente, i prelati molto spesso sono uomini come tutti noi, come noi si sono scelti un mestiere. Il lasciare andare che non nega il dolore, quello invece è interessante. Stare in quella perfetta letizia e fare quel che c’è da fare … quelli sì che sono ***** …
2 Aprile 2016 alle 5:53 pm
Aaaah miscredente! In panciolle nella perfetta letizia, non ti vergogni?
E l’inferno, eh? Non ci penzi che potresti finire arrosto?
Pensare che quel povero figlio del Bertone ha dedicato la vita a voi peccatori!
Vabbe’…
3 Aprile 2016 alle 4:27 pm
@8 E’ esperienza comune; la fede è di norma insegnata come il contrario della mis-credenza (ciò che al gruppo non piace), anziché come il contrario della (anche se preferirei forse la risposta alla) paura (il che non significa negarla, ma non aggrapparsi/farsi trascinare da essa).
Tuttavia, resta l’aforisma di Cioran: “Trovare che tutto manca di fondamento e non chiuderla lì è un’incoerenza che in realtà non lo è…”
@9 Mi vien da rileggere una facile battuta di questi giorni: che sia l’ineffabile porporato l’autore dei nuovi “Attici degli apostoli”…
3 Aprile 2016 alle 5:21 pm
@9 tanto mica mi ci vorranno ugualmente in paradiso … e comunque quale inferno/paradiso tra i tanti? No perché facendo quello che dice tizio finisco nell’inferno di caio e viceversa …
@10 però: se ci si salva per Grazia, ha senso aver paura?
3 Aprile 2016 alle 7:36 pm
“Gli attici degli apostoli” non è male.
A proposito di @10 e @11, mi viene in mente la storia del peccatore gaudente, per nulla pentito, che sino alla morte gode sfrenatamente dei piaceri del mondo. Arrivato nell’aldilà, viene introdotto in un edificio lussuoso dove un signore elegante di nome Satana gli comunica che si trova all’inferno e che secondo la procedura gli verrà assegnata una sede, che spera sarà di suo gradimento ecc. ecc. Detto fatto: una bella signorina sorridente accompagna l’ormai ex peccatore in una villa con parco piscina sauna sala massaggi palestra servitù e ogni tipo di confort. Prima di andarsene dà il suo numero di cell al nostro stupito amico dicendo di chiamarla per “qualsiasi cosa potrebbe desiderare”. Sempre più stupito e timoroso di qualche trappola, accompagnato dal maggiordomo, si mette ad esplorare la grande villa sino a che al fondo di una salone vede una pesante tenda rossa, mossa come da un vento. Il maggiordomo gli sconsiglia di avvicinarsi assicurandogli che non è una zona “interessante” ma lo stupito neo dannato vuole andare sino in fondo, si avvicina alla tenda la scosta e vede… un’enorme fornace ardente dove migliaia, milioni di persone patiscono le pene dell’inferno incalzati da una miriade di diavoli inferociti. Con aria tremante chiede al maggiordono: “Ma quello, che posto è?”. “È l’inferno dei cattolici, signore, a loro piace così…”.
4 Aprile 2016 alle 10:40 pm
Però un cristiano veste la sofferenza di un valore/significato, per cui credo non ci possa essere più di tanto spazio per il dialogo. O forse no.
5 Aprile 2016 alle 8:55 am
Non mi pare che Gesù desse un particolare valore positivo alla sofferenza. “Padre allontana da me l’amaro calice” e “Padre, perché mi hai abbandonato?” non sono propriamente apprezzamenti verso ciò che avrebbe patito e quello che stava, poi, patendo. È vero però che nella tradizione cristiana, anche per dare una giustificazione alle pene del giusto (quello che, essendo in armonia con i voleri del Signore, dovrebbe essere al riparo dalla disgrazia), si dice che i patimenti di oggi saranno la gloria e il paradiso di domani.
Su questo si può dialogare, eccome. Anzi, se conosci un cristiano, prova un po’ a discutere di queste cose… Secondo me provare a comprendere e comprendersi su questi temi non può che far bene a tutti.
5 Aprile 2016 alle 12:02 pm
mah .. un po’ lo dà, valore positivo … la sofferenza diventa qualcosa che concorre al rimedio a quel che si fa … ci rende beati (“beati i perseguitati, gli afflitti, chi viene perseguitato, insultato “, ecc) … poi tradizionalmente si può dare un senso al “soffrire per” anche quando non ne ha senso alcuno … vedi anche eutanasia e diritto a scegliersi una morte dignitosa…la vita viene espressa in un purgatorio per il regno … boh, forse con i Cristiani si riesce a discutere, hai ragione, basta mettersi dalla parte del torto e del dubbio e farsi tollerare.
5 Aprile 2016 alle 12:13 pm
Buondì. Quella barzelletta sull’inferno, cristiano e no, mi ha sempre lasciato un po’ perplesso.
Casualmente sto rileggendo Santideva, il Bodhicaryavatara. Qui troviamo espressioni che possono non dispiacere anche a molti cristiani.
Ad esempio il cap 2, ‘Confessione dei peccati’.
Oppure 4;21 (Basta il peccato di un istante e uno resta per un evo intero nell’inferno Avici).
O 6;21 (Il dolore ha una grande virtù perchè, col turbamento che ispira, abbassa l’orgoglio, eccita pietà verso le creature, fa temere il peccato, fa amare il buddha).
E via dicendo.
Forse c’è buddismo e buddhismo, come c’è cristianesimo e cristianesimo?
5 Aprile 2016 alle 12:33 pm
@15: sì, hai ragione, “beati gli oppressi e i perseguitati” sembra sull’onda di “è andata bene perché è andata male…”. Qui nasce un discorso particolare: secondo me Gesù non incoraggia il patire in quanto tale ma la capacità di proseguire sulla propria strada non ostante tutto. Ossia non curarsi (lasciar andare?) dei costi nel seguire la via.
Se per poter ragionare con un cristiano riesci a metterti dalla parte del torto e del dubbio e a farti tollerare: beato! 🙂
5 Aprile 2016 alle 12:41 pm
@16: ciao Doc. Santideva non l’ho mai frequentato. Comunque certamente c’è buddismo e buddismo, e a un certo punto occorre dichiararsi altrimenti è tenere il piede in più scarpe.
Lo zen è una linea di buddisti dove si sostiene la possibilità di trovare in sé stessi la matrice del comportamento etico.
Però siccome non è un discorso agevole né proponibile a tutti, anche nella scuola zen circolano indicazioni intermedie.
Per esempio anche in alcuni monasteri della scuola zen giapponese ogni quindici giorni c’è una sorta di (vuota) cerimonia in cui la comunità dovrebbe confessare i propri peccati.
E poi in molti sutra (minori) si parla di inferni e paradisi in termini seri, come se fosse certa la loro esistenza.
Occorre sempre tenere conto di quale problema ci stiamo occupando e con chi: in ogni caso se raccomandi di fare i bravi e sopportare con pazienza le pene della vita non combini grossi guai.
5 Aprile 2016 alle 1:40 pm
@17 sì … ma “beati gli afflitti”? e poi “non curarsi dei costi” ok ma viene letta spesso come “abbiamo ragione in ogni caso, per fede/grazia” … dare un senso/significato alla sofferenza per me è difficile, sono dell’avviso che come proponeva (credo Heller) era meglio avere una insegna al neon in fronte che lampeggia invece…. Per avere un senso occore un disegno, un progetto, e non so immaginare lo scopo del cancro al pancreas, per esempio, se qualcuno volesse chiedere al nostro Ingegnere Capo…
Trovo più ragionevole dare un senso a quel che si fa, a come si affronta, a come uscirne… a ricavarne per quel che si può un costrutto… ed a accettare quando non si capisce una beata mazza di quel che accade…
5 Aprile 2016 alle 4:37 pm
@19: il “discorso della montagna” è molto bello ma sono affermazioni assolute che tendono a creare una scala di valori. La mia chiave di lettura è nella prima frase: “Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli” qui ci leggo la povertà dello zz.
Per quanto riguarda il senso della sofferenza, grazie al cielo, “noi buddisti” non ci occupiamo di simili problematiche: nella nostra parrocchia è sufficiente farla sparire.
In effetti, però, c’è un buddista che se n’è occupato: diceva che il senso della sofferenza sta nel ricordare ai pigri che è ora di fare zz 😛
7 Aprile 2016 alle 9:42 pm
Si dice: “è questione di percezione”. E’ questione di “percepire” di star bene, di non provare dolore, di non soffrire … di essere liberi, e via menate discorrendo? E’ solo “fare il pane con la farina che si ha” … e anche no allo stesso tempo. Non è possibile trovare un riferimento comune assoluto, ha senso un dialogo, un ascolto, un “vivi e lascia vivere” … dialogo sulla sofferenza è un ossimoro (. o ?)
8 Aprile 2016 alle 10:57 am
Ciao Max. Sei sibillino.
Quando “parlando buddista” si dice che è questione di percezione, si intende che ciò che non percepisci non ti dà alcun dolore. Percepire di star bene è già mettere le basi del dolore.
Il resto mi suona troppo oscuro, quando vuoi puoi essere più chiaro?
Grazie
Ciao
10 Aprile 2016 alle 8:27 am
In @6 scrivevo “c’è un grosso, grossissimo problema culturale da affrontare in tutte e tre le religioni abramitiche, che riguarda la scrittura. Sino a che non lo si affronterà a fondo ci saranno guerre per motivi misti alla religione, come ci sono ora”. Sembra che la realtà ce la metta tutta per darmi ragione.
10 Aprile 2016 alle 12:35 pm
@23: intervistatrice donna… doppio problema per il manager politico religioso (in una parola: del Potere), letteralmente “spalleggiato” dai libri… Chissà quale sarebbe stato il commento di Ida Magli (Il mulino di Ofelia)…
10 Aprile 2016 alle 1:50 pm
Forse avrebbe parlato del “possesso delle donne”…
Spalleggiato, spalleggiati, soprattutto da un libro che se non verrà riletto in chiave spirituale, se rimarrà la base culturale, concreta, normativa e legislativa di più di un miliardo di persone porterà alla catastrofe.
26 Agosto 2018 alle 8:59 am
Buongiorno a tutti; stavo leggendo, anche se con estremo ritardo, il pdf che è qui in allegato. Devo dire che sono molto attratto da questo genere di argomenti, e quando si parla di sofferenza per me già significa disquisire di qualcosa per cui vale la pena veramente di spendere il proprio tempo. Dal testo ho avuto modo di apprendere senza dubbio degli spunti di notevole interesse, come quello in cui viene citato l’attaccamento quale fonte di sofferenza; devo dire che, a partire dalla mia stessa esperienza di vita, questa è una verità che devo riconoscere come sacrosanta. Ci sono degli altri punti, però, che onestamente non riesco a comprendere pienamente, e in particolare devo rilevarne uno che diviene poi l’ origine e la fonte delle riflessioni che ora seguiranno. Si parla, con accezione negativa, della sofferenza, nei termini di un qualcosa che sarebbe meglio eliminare dalla propria vita definitivamente, qualcosa da cui scansarsi, da allontanare, diciamo, per sempre. Però poi, proseguendo nella lettura del documento, mi rendo anche conto che la sofferenza è l’input, diciamo lo starter, che ci fornisce la giusta motivazione per intraprendere un cammino di liberazione; quindi, se non ho capito male, la sofferenza non è un male per se stesso, ne tantomeno un bene, ma diciamo che si colloca relativamente agli esiti che essa stessa innesta. Ecco che poi mi si presenta la seguente riflessioe; come il manubrio del pesista gli fornisce la giusta resistenza che sarà tanto proficua allo sviluppo del suo sistema muscolare, così anche la sofferenza indotta dalla costanza di una retta pratica, perché alla fine comunque il cammino comporta sacrificio e, quindi, se così vogliamo chiamarla, sofferenza, produrrà un certo sviluppo delle potenzialità volitive dell’individuo stesso, e questo credo vada a suo vantaggio, perché volontà e motivazione si alimentanto e si accrescono a vicenda. Allora potremmo forse dire, ancora una volta, che la sofferenza non è un male per se stesso come, del resto, non è nemmeno un bene per se stesso; sarebbe un male se Tizio, vivendo pieno di angoscie per i suoi attaccamenti, non sfruttasse tale stato di disagio per compiere uno scatto evolutivo nella propria condotta di vita. Ok, allora, forse, potremmo dire che la sofferenza può anche essere utile in itinere ma che, alla fine di un percorso di crescita, essa va estirpata dalla propria anima. Però poi mi chiedo: ma è davvero alla nostra portata estinguere il focolaio della sofferenza, intesa in un senso globale? Io abito davanti al Policlinico di Roma, e al decimo piano sono tenuti in cura i bambini del reparto di oncologia pediatrica, che spesso ho avuto modo di vedere; per questo io mi chiedo, é possibile che una madre possa smettere di soffrire per la condizione di prostrazione in cui versa il proprio figlio? Certamente se una madre, china sul proprio dolore, si dimenticasse del mondo esterno, inclusi gli altri figli che non riesce più ad accudire ma che ancora, piccolini, hanno bisogno di lei, allora potrei anche pensare che una sorta di attaccamento morboso alla vita, collegato a una mancata accettazione dell’impermamenza delle cose, compresa la stessa vita di suo figlio, si siano installati in lei; ma fatta eccezione per questi eccessi, chi potrebbe biasimare il dolore di una madre che vede suo figlio patire in quel modo? Allora io credo che, molto più realisticamente, ci sia sicuramemte una sofferenza negativa, che scaturisce dagli attaccamenti e dalle paure; d’altra parte, però, non posso fare a meno di notare che esiste, accanto alla prima, anche una sofferenza di compassione, che non si identifica con un becero sentimentalismo, ma che esita invece da un atto di amore, come quello di un padre che si alza ogni giorno alle 5 di mattina e che nonostante la stanchezza, e quindi la sofferenza, intascate le chiavi della propria auto, si fa i suoi bei 70 km per raggiungere la sede di lavoro, e questo solo perché vuole provare a garantire un futuro dignitoso alla propria famiglia.
La mia personale opinione, in conclusione, è che l’amore spesso, anche se non sempre, va a stretto braccio con la sofferenza ( quella “buona” intendo), e che una vita felice non è una vita priva di sofferenza ma una vita carica di “alterità”, di “cuore” e di “valore”, che sa persino soffrire per il dolore degli altri.
3 Settembre 2018 alle 5:30 pm
Caro Vincenzo, benvenuto. Con ritardo ho trovato il tempo di leggere il suo commento. Se in futuro volesse di nuovo intervenire tra le pagine di questo blog, le chiedo la cortesia di essere più conciso. L’abitudine, nell’uso del web, è che esso fornisca spunti veloci, da approfondire in altra sede, forse. Gli scritti troppo lunghi rischiano di rimanere non letti. Un saluto, mym
1 Ottobre 2018 alle 2:23 pm
Milioni di kalpa addietro, nella casa dei Buddha e dei Patriarchi, un antico Buddha mi trasmise la dottrina pronunciando le seguenti parole: “Fai il bravo, fai zazen e non rompere le scatole”.
Penso che il testo sulla sofferenza sia chiaro: il pensiero che insegue ciò che desidera è la fonte della sofferenza, invertire la rotta verso il non-pensiero (il “vuoto” da cui il pensiero nasce) è la via buddhista. Metterlo in pratica momento per momento è difficile però la vicenda del peccatore gaudente (@12) ci insegna che la realtà è sempre diversa dalla nostra immaginazione, quindi perché vivere nell’illusione :)))
1 Ottobre 2018 alle 5:02 pm
Nel non rompere le scatole, mi confidò quell’antico Buddha, è compreso anche non scrivere commenti… 😛
Comunque concordo: se lasci libera la scimmia di far guai… sono guai. Se l’agguanti subito e la lasci scomparire è un’altra storia.